OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Raccomandazioni di carattere generale.
La pandemia da SARS-CoV-2 presenterà nei prossimi giorni ulteriori criticità.
In tale contesto, continueranno a rilevarsi nella popolazione sentimenti di angoscia
e particolari necessità di assistenza, si potranno accentuare i momenti di tensione, gli
atteggiamenti di irresponsabilità, le condotte non consone, la diffusione di notizie non
controllate e prive di fondamento.
Sullo sfondo di una situazione che si presenta molto complessa, tali fenomeni
rendono la gestione della situazione, per quel che riguarda il nostro lavoro, ancora più
difficile e gravosa.
Ad un operatore di polizia si richiedono, in tali situazioni, molte doti:
preparazione, equilibrio, generosità, resilienza, spirito di sacrificio.
Sebbene gli strumenti che l’ Amministrazione ha messo a disposizione affinché
queste doti costituiscano bagaglio di ogni operatore non siano sempre stati pienamente
adeguati o perseguiti con un programma sistematico e razionale, rispondendo talvolta a
condizioni emergenziali, i risultati del lavoro svolto fino ad ora sono stati straordinari.
Il permanere delle situazioni di difficoltà, che si protrarrà ancora per un tempo non
breve, impone tuttavia di centrare l’attenzione su alcuni aspetti importanti, che devono
rappresentare lo sfondo di riferimento comune di tutti gli interventi e le attività che
dovranno essere ancora garantite.
Il primo aspetto è rappresentato dalla conoscenza delle indicazioni e delle misure
di comportamento vigenti e dalla piena adesione dei comportamenti lavorativi e non alle
stesse.
Nelle ultime settimane la diffusione del virus è di gran lunga predominante in
ambito familiare e comunque extralavorativo, situazioni in cui vengono facilmente meno
le cautele e le norme di profilassi.
Spesso, nella nostra comunità, il momento di contagio è rappresentato da
occasioni (pausa pranzo, riunioni conviviali, ecc.) in cui l’attenzione è minore, con
meccanismi che, seppure comprensibili nelle loro dinamiche, finiscono per esporre
all’infezione, in una unità di tempo, più dipendenti di uno stesso settore; ciò finisce per
compromettere ancor di più la funzionalità degli uffici in un momento così particolare.
Frequente, pure, durante l’attività di contact tracing svolta dagli uffici sanitari, il
rilievo di comportamenti non conformi alle misure di profilassi durante il servizio: a tali
comportamenti, al di là dei possibili profili disciplinari, consegue l’adozione di un numero
elevato di provvedimenti di quarantena, con ulteriore depauperamento della forza
disponibile.
Si richiama fortemente, pertanto, la necessità di aderire alle misure di
comportamento semplici e note (distanziamento, utilizzo della mascherina, igiene delle
mani) e di intervenire con i colleghi che mostrano atteggiamenti non consoni alle stesse.
Se ci si adegua a tali comportamenti, la qualificazione di “contatto stretto” è relegata a
casi del tutto particolari e straordinari.
Il secondo aspetto, forse preliminare al precedente, su cui si richiama l’attenzione,
è l’atteggiamento corretto davanti alle misure di contenimento dell’infezione individuate
dall’ Amministrazione.
Da questo punto di vista, tutte le iniziative, le misure, i protocolli le circolari
emanate sono state rigorosamente ispirate a criteri di scientificità e di affidabilità,
evitando ogni misura di non comprovata e documentata evidenza tecnica e professionale.
Ogni intervento è stato peraltro contestualizzato, a differenza di quanto avvenuto
in altri contesti lavorativi, alla specifica attività prestata dagli operatori di polizia ed ha
potuto essere continuamente monitorato, nell’efficacia, dai rilievi epidemiologici
garantiti, sin dall’inizio, dagli uffici sanitari.
Una precisazione, tuttavia, è d’obbligo: i protocolli emanati (quali, ad esempio,
quelli per definire i cosiddetti contatti stretti, il tipo di accertamento da eseguire, il tempo
in cul è preferibile effettuare il tampone naso-faringeo, le modalità del rientro in servizio
dopo la quarantena o la malattia), per quanto rigorosi e dettagliati, non potranno mai
rappresentare strumenti che rendono l’intervento del medico meramente esecutivo ed
acritico. Se così fosse, tale professionalità potrebbe essere agevolmente sostituita da
figure senza competenze specifiche.
In realtà, tutti 1 protocolli e le linee guida, che si fondano sull’esame delle prove
disponibili al momento, all’interno del modello di medicina basata sull’evidenza, indicano
tutte le possibili opzioni di intervento e contengono algoritmi decisionali o di calcolo da
elaborare per la scelta concreta, che resta del singolo professionista e che richiede
specifiche competenze ed esperienza.
Le richieste di protocolli che uniformino in maniera assoluta ogni azione e
decisione, che continuano a pervenire da alcuni uffici e organizzazioni sindacali a questa
Direzione, sembrano invece muovere dall’errata convinzione che esistano azioni e
interventi “universali”, semplici e vincenti, per l’eliminazione del rischio o per la sua
massima attenuazione.
E bene riflettere, invece, sul fatto:
– che le linee guida tracciano percorsi vari da seguire in base alla disponibilità dei
dati, alla presentazione del caso concreto, all’analisi di tutte le molteplici variabili che si
presentano inevitabilmente;
– che la decisione finale, sulla base di una elaborazione intellettuale e non
esecutiva né automatica, spetta solo a chi ne detiene le competenze professionali e,
conseguentemente, ne risponde anche in termini di responsabilità;
– che la rapida evoluzione della pandemia e delle conoscenze ad essa correlata
impongono modulazioni ed integrazioni altrettanto veloci.
La conoscenza di tali dinamiche dovrebbe comportare un atteggiamento di
affidabilità e di fiducia da parte dei non addetti ai lavori, evitando iniziative
personalistiche, improvvisazioni, protagonismi non qualificati, comunicati pubblici che
finiscono per alimentare un clima di incertezza e di confusione che non giova alla gestione
di situazioni già critiche di per sé e non aiuta chi ne è responsabile.
Il terzo aspetto da affrontare in questo momento è l’approccio psicologico
dell’operatore di polizia.
La seconda fase della pandemia, riproponendo temi e scenari che si pensava
fossero definitivamente superati, può acuire senso di scoramento e di rassegnazione in
ogni persona. Per chi svolge professioni d’aiuto, come per operatori sanitari e di polizia,
il continuo far fronte a contesti emergenziali può ingenerare un senso di impotenza e di
esaurimento funzionale ed affettivo.
È importante essere consapevoli che la pandemia finirà comunque nei prossimi
mesi e che, al di là del numero dei contagi, il decorso della malattia non è critico nella
maggior parte dei casi, pressoché costantemente in assenza di note condizioni
predisponenti.
È allo stesso modo necessario ricordare come i possibili interventi di un operatore
dedito al soccorso di terzi, nelle condizioni di emergenza, sia per definizione deficitario
rispetto alle richieste; tuttavia, allo stesso modo, la quota di quello che può concretamente
fare rappresenta un’azione irrinunciabile ed importantissima ed è a quello che si è fatto
che si dovrà pensare alla fine del servizio, non a ciò che non è stato possibile fare.
Non servono atteggiamenti di stoicismo e di sovraesposizione: salvaguardare 1l
proprio stato di salute in questa fase è prioritario anche per la tutela dei propri cari, dei
colleghi e della popolazione. Da questo punto di vista si ribadisce perentoriamente
l’indicazione a non recarsi in servizio ogni qualvolta siano presenti sintomi che possano
essere correlati a COVID-19 e si richiama la necessità di aderire strettamente alle
procedure di profilassi raccomandate: i corretti modelli di comportamento costituiscono,
oltre che strumenti per tutelare la propria salute, un esempio per tutta la popolazione.






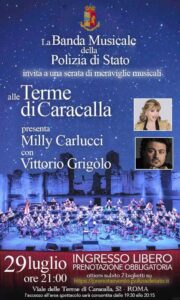
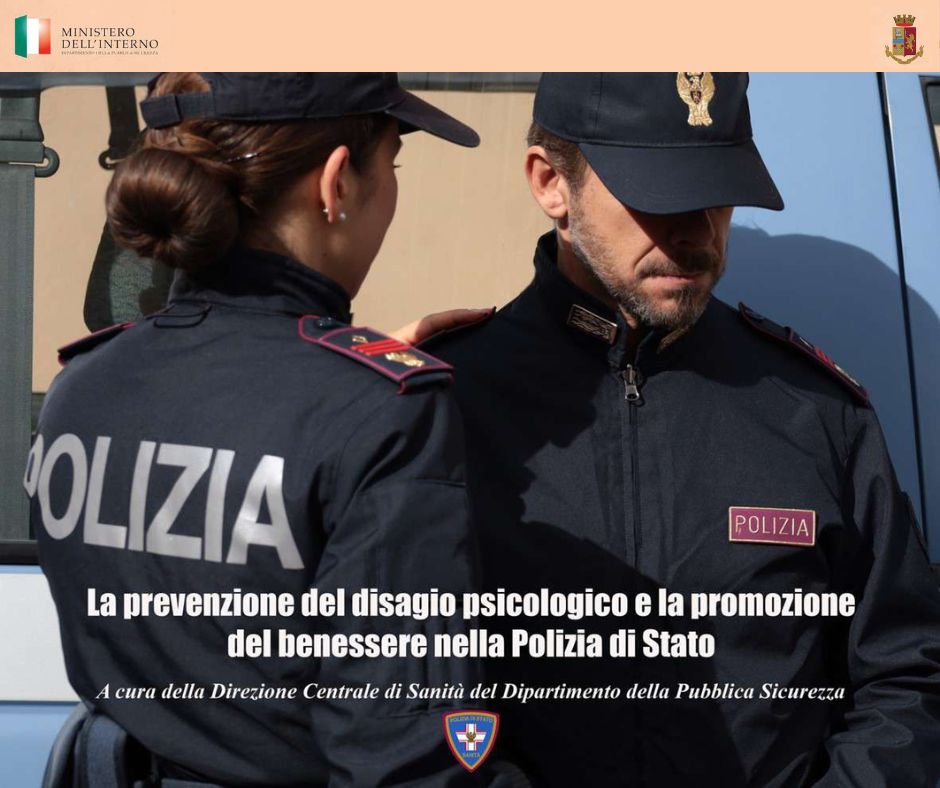







0 Comments